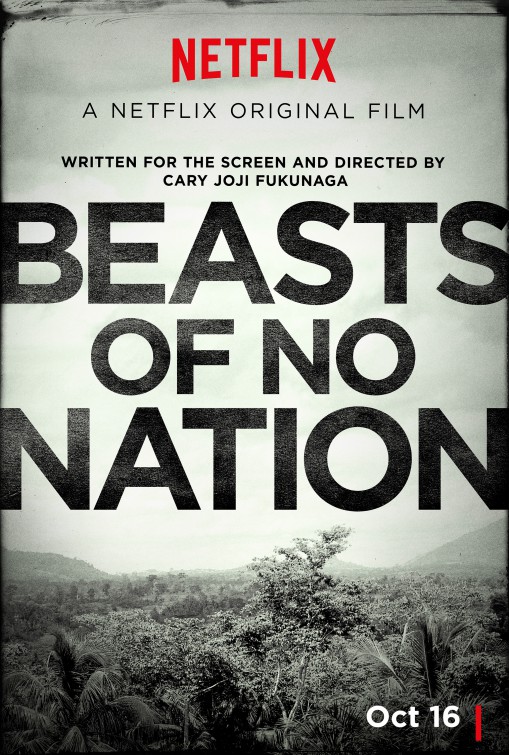Venezia 2015: on the ground (i film mediocri o nella media, in concorso e non)
Venezia fondata, infondata, affondata: cinema nuovo, cinema vecchio. Sentimenti passati in lavatrice. Siamo ridotti a stracci, e sarebbe potuto accadere grazie a questi film.
Beasts of No Nation, regia di Cary Fukunaga (USA) – In concorso ♥♥½
Qualcosa di quel logo Netflix nei titoli portava a storcere il naso. Beast of No Nation è in grado d’avere prestigio automatico per le firme che porta, ed il risultato non è deludente. Si tratta di un ipercompresso scadenziario di avvenimenti listati come tali. Appeal pulito da serie, trattazione di violenza en passant, enfasi scemata continuamente e riversata più nel colore e nella messa a fuoco che negli atti che dipinge. Mai stupro/omicidio fu così soft, così appetibile, così innocuo. Fukunaga cade nella rete della nuova TV e del (speriamo di no!) nuovo cinema, così in grado di fondersi nella confusione narrativa audiovisiva con i prodotti destinati alle visioni casalinghe da proporre efferatezza da bibita a volontà, ma mai una linea di febbre che sia una. Sedata e sotto controllo, questa visione dell’apparato raccontante è un passo nell’oblio , inteso come chiarificazione anestetica e variopinta di ciò che dovrebbe essere oscuro e/o disturbante. Le vibrazioni di Beast of No Nation lasciano lo spazio all’induzione narrativa tanto quanto lasciano orfano l’occhio di materia visiva da poter opporre al proprio sentimento. Rimane l’interpretazione di Idris Elba, assieme a un pattern di colori inequivocabilmente attraente: ma di questa bellezza calibrata non sappiamo che farcene.
Cose che ci siamo, volenti o nolenti, portati a casa da Venezia72: i brontolii di Idris Elba. I sospiri stanchi, gli sbuffi irritati, i rantoli fortuiti sono appendici rivelatrici, grassetti di naturalezza irrequieta che segna(la)no la fatica esistenziale di un corpo ingombrante e sozzo, insudiciato dalla propria hybris, tracotante di sudore, rabbia, frustrazione, odio, violenza, un pifferaio magico che millanta trofei da conquistare (e stuprare) ai suoi bambini rapiti e ipnotizzati dagli spari; una presenza massiccia e catalizzante che attira su di sé la simbologia del suo film furbesco, la putrefazione del suo paese sfregiato.
El Clan, regia di Pablo Trapero (Argentina/Spagna) – In concorso ♥♥♥
Cinema energico, stiloso, vecchia scuola. Se per “vecchia scuola” intendiamo tutto quel meccanismo calligrafico di color correction e fluidità di macchina. Cinema di genere, cinema sul Novecento. Rapimenti, il comico Guillermo Francella in un ruolo gelido e spietato. Trapero misura abilmente detto e no detto, mostrato e non mostrato. Non piange, non compiange: adopera un’attitudine funk per far sì che la cronaca nera diventi colorata. Il guizzo è quello dell’entertainment, lo stile è trasversale ed internazionale. Senza supremazia, è comunque un piacere ritrovarsi ad un cinema pulito ma non ripulito, macabro e divertito.

Remember, regia di Atom Egoyan (Canada/Germania) – In concorso ♥♥♥+
Nazismo, terra da sempre fertile per il cinema. Anche – o soprattutto – ora che può farsene scudo, valido ancoraggio per un thriller lineare e stuzzicante secondo i dettami del giallo chiuso ermeticamente, compiuto nella sua semplicità simbolico-allegorica, ma altrettanto insoddisfacente a visione compiuta. Egoyan si gioca bene le sue carte, ma la sua è una mano sicura, dove la calma e la compostezza guidano la narrazione protetta dal twist – più o meno prevedibile – che corona la ricerca del significato ma non quella del viaggio cinematografico. Si tratta di vendetta, subdola vendetta, tramite un’abilità di rovesciamenti talmente misurata nella realizzazione da lasciare sbigottiti per uno, due istanti prima di assistere all’appianamento generale. Remember agisce per tinte unite, le sfumature sono assenti: l’equilibrio non viene praticamente mai spostato e il genetico dubbio legittimo che la vicenda porterebbe in sé diventa solo una possibile applicazione, lasciata (s)correre tra le sicurezze.
Lo osservi e non lo riconosci, Atom Egoyan, nel passo lieve e addensato d’ombre sottili che intraprende approcciandosi alla storia – rischiosamente tragicomica – di un anziano ebreo, piagato dalla demenza senile, che si mette sulle tracce – mappa del nero tesoro alla mano – del nazista che ha sterminato la sua famiglia. La Storia è alle spalle, il presente è nebuloso, il passato privato è reticente: la prima gli presenterà un conto più alto di quanto si aspettasse, il secondo gli dimostrerà quanto l’eredità dell’orrore germogli (in)/(mal)sana e forte, il terzo determinerà infine la lancinante agnizione sul proprio posto (e senso, e futuro) nel mondo.
The Danish Girl, regia di Tom Hooper (Gran Bretagna/USA) – In concorso ♥♥
Tom Hooper è un pittore. Tom Hooper è più bravo a dirigere cinema di quanto Eddie Redmayne sia bravo a recitare. Ritroviamo il viso di Stephen Hawking in abiti femminili. La tematica è forte – sessualità e identità di genere – e Hooper, con fare da Hollywod classica, confeziona un prodotto necessariamente misurato per permettersi lo sfarzo visivo che ne determina l’atmosfera. In un’orgia di colori che lasciano al caso una singola inquadratura c’è poco spazio per il turbamento profondo, e ci dobbiamo accontentare di un quadro ad olio sincero nella sua semplificazione, apprezzabile nel suo sottendere i concetti attraverso il dramma scaturito tra i personaggi e non in nome di qualche – anche ambigua – oggettività. The Danish girl preferisce essere un film di pochi punti saldi tutt’altro che censorei, piuttosto che toccare corde che non può far vibrare fino in fondo.
La ragazza danese non è la (soon-to-be) Lily, bensì l’unico raggio di luna e sole dell’ingessatissimo, legnoso, marmoreo e compassato film di Tom Hooper (che smarrisce qui anche quel pulviscolo di inventiva visiva che aveva spremuto in Il discorso del re): Alicia Vikander, moglie coraggio che affronta una via crucis mano nella mano con un affettatissimo Eddie Redmayne (Oscar dove, Oscar chi?). Tutto il resto è (gran)(uber)noia.
Anomalisa, regia di Charlie Kaufman e Duke Johnson - In concorso ♥♥♥
«Quando vedo un volto o ascolto un nome o conosco qualcuno di nuovo, non mi interessa: sono tutti uguali, e nessuno di loro sei tu» si strugge Tom Noonan (firmato Carter Burwell) sui funerei titoli di coda. Ma il tu non esiste, è creazione interrotta, è carta bruciata in sogno, è copia carbone indigesta, non È. Tuttavia abbiamo bisogno di illuderci, ci ricorda Charlie Kaufman nel suo canto cartoon depressivo e catatonico; di credere in quel tu, in quel noi. Di credere che un giorno smetteremo di essere morti.
Francofonia, regia di Aleksandr Sokurov (Francia/Germania/Paesi Bassi) – In concorso ♥♥
Per sokuroviani di ferro,Francofonia vince lì dove l’occhio riesce a ricollegare la pellicola all’opera precedente del regista. Per tutti gli altri c’è la demo di un viaggio ineluttabilmente incompleta nella storia e nell’immagine: dalla prova di Sokurov ci arriva una parzialità che è infine troppo lontana dalle sue opere precedenti; non tanto per il questa volta limitato accumulo, ma per un’ottica che pare indecisa dall’inizio alla fine, insopportabilmente immobilizzata in una manciata di contrasti e in un impianto paratelevisivo che delegittima troppe porzioni del film.
Spotlight, regia di Thomas McCarthy (USA) – In concorso ♥♥♥
Gruppo di giornalisti in un interno, pareti bianche che disegnano un geometrico, ordinato telaio di sospetti, dicerie, bisbiglii, informazioni, conferme, certezze, dichiarazioni, e gangli di indignazione, tormento, conflitti, rese dei conti e prese di coscienze. Cinema di stampo civile, cinema portatore sano di denuncia, cinema di divulgazione necessaria, cinema di rigore lineare, cinema tutto d’un pezzo, cinema che (ci)(vi) va bene.
Qui la recensione a cura di Sandro Lozzi