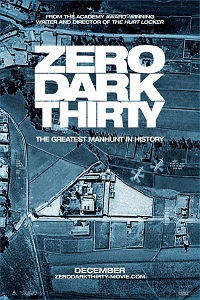ZERO DARK THIRTY di Kathryn Bigelow

REGIA: Kathryn Bigelow
SCENEGGIATURA: Mark Boal
CAST: Jessica Chastain, Jason Clarke, Joe Edgerton, Jennifer Ehle, Kyle Chandler
NAZIONALITÀ: USA
ANNO: 2012
USCITA: 7 febbraio 2013
“L’ira si trasforma in gioia, la collera in serenità;
ma una nazione devastata non si può riportare al benessere,
i morti non si possono riportare in vita.”
L’Arte della Guerra, Generale Sunzi
«Oh my God».
Una manciata di parole su uno schermo nero.
E’ quel che resta dell’11 settembre.
L’ultimo Kathryn Bigelow è percorso a ritroso, (ri)parte dalle Twin Towers per attraversare undici anni di storia (non solo) americana. Il contenitore definitivo, la pietra (tombale) posta su una determinata tipologia di produzioni statunitensi, intente a specchiarsi, più o meno esplicitamente, nelle conseguenze derivanti dall’11 settembre: La 25esima ora come The Kingdom, World Trade Center e Redacted, Rendition e, perché no, Road to Guantanamo. Zero Dark Thirty è testamento lasciato in dono ai posteri, cronaca ricreata secondo le regole della fiction, eppure rigoroso come solo le grandi ricostruzioni storiche sanno essere. Ciò nonostante concept di testa, cuore e pancia, sentimenti e rimorsi, ansie e violenza, glacialità di superficie e calore sottocutaneo divampante. L’ultimo Bigelow è tutto ciò che l’ha preceduto: ferita profonda, mai rimarginata e di fatto immune alla cicatrizzazione, abusi subiti e inferti, lacrime e sangue, ristagno di violenze fisiche e mentali, drammi collettivi, raggiri democratici, caccia all’uomo e “guerre di pace”; il film di una nazione intera. Kathryn Bigelow sceglie il rigore come strada maestra e sentieri prossimi al procedural come battistrada: guarda a 24 e ad Homeland rifuggendone i movimenti di macchina virtuosi e (neo)televisivi, affidandosi invero a soluzioni stilistiche caste, che sono diretta conseguenza dell’innovatore The Hurt Locker, asciutto pregresso senza il quale Zero Dark Thirty non avrebbe motivo, formale, d’esistere.

“Lascio una scia bianca e inquieta, acque pallide, facce più pallide, dovunque passo. Le onde invidiose si gonfiano ai lati per sommergere la mia traccia: facciano, ma prima io passo.”
Moby Dick, Herman Melville
Zero Dark Thirty è mosso da un sentimento che lambisce l’ossessione, un’indole viscerale di stampo letterario, il racconto di un assillo d’ispirazione “melvilliana”, celata nelle profondità remote del film. Abu Ahmed è il capodoglio, la balena bianca braccata per 157 minuti: l’identità segreta, il nickname da battaglia, la doppia personalità, il presunto morto all’esistenza del quale nessuno crede o sembra (non) voler credere; fatta esclusione del suo cacciatore: Jessica Chastain, vera e propria protesi della Bigelow di fronte la macchina da presa. Maya rappresenta l’eccezione pressoché isolata all’interno di una filmografia prevalentemente al maschile, che di rado ha collocato tratti femminili come primi attori della vicenda, in questo frangente persino più centrali se paragonati alla Jamie Lee Curtis di Blue Steel. All’epoca “solo” una protagonista, non (ancora) il riflesso sullo schermo della sua regista. Kathryn Bigelow sceglie lei, Jessica Chastain: elemento pietrangolare in Zero Dark Thirty, caparbietà fatta donna in un mondo di (quasi-soli) uomini, ologramma attoriale dell’autrice alla quale vengono affidate le chiavi, emotive e metaforiche, del film diretto come se fosse l’ultimo, quello di una vita intera. Naturale quindi, che una pellicola sulla carta potenzialmente corale, si trasformi ben presto in un assolo al femminile, un monologo che esponenzialmente cresce, attraversando il disgusto iniziale senza nazionalismo alcuno, bensì grazie al rispetto della cultura nemica (il velo, indossato durante gli interrogatori) e alla testardaggine di chi sa di dover sudare il doppio, prima di essere presa, realmente, in considerazione. Kathryn Bigelow e Jessica Chastain, due facce della stessa medaglia. La seconda animazione sul grande schermo della prima, che remota, a sua volta, la guida.

“Eleanor Rigby, died in the church and was buried along with her name.
Nobody came.
Father McKenzie, wiping the dirt from his hands as he walks from the grave.
No one was saved.”
Eleanor Rigby, The Beatles
L’ultimo Kathryn Bigelow è immediato effetto di The Hurt Lokcer, a sua volta il vero Point Break all’intero del percorso filmografico dell’autrice, il propellente capace di stravolgerne le coordinate tutte e di proiettarla nell’olimpo di Hollywood. The Hurt Locker più della parentesi Il mistero dell’acqua, sospetto di cui Zero Dark Thirty diviene prova: siamo di fronte ad una nuova Bigelow, evidentemente mutata nella forma, ciò nonostante fedele a se stessa, comunque identica nella sostanza. La conferma arriva dalla spontanea similitudine attoriale tra Jessica Chastain e il suo predecessore militare Jeremy Renner, con la prima destinata a rivelarsi come estrema declinazione dei caratteri riconducibili al secondo. Entrambi viventi in quanto esseri di guerra ma, rispetto alla Maya di Zero Dark Thirty, il sergente William James di The Hurt Locker appare ora come emotivamente privilegiato: in quanto potenzialmente collocato dinanzi a una scelta (famiglia o lavoro). Libero arbitrio che non viene concesso a Jessica Chastain, lei è il suo ruolo, vive di e per la sua missione, non può o forse non vuole permettersi altro, così da costruirsi una condizione di orfana senza casa e alternativa che non sia la sua scrivania; un potenziale supereroe dall’identità segreta: solo, solitario e sconosciuto ai più. Sopratutto in caso di successo, per questo avvicinabile alla maschera di tristezza, rassegnazione e antieroistica dedizione alla bandiera già indossata dal Ben Affleck di Argo; anche qui, se “vittoria” verrà conseguita, in essa non sarà contemplato alcuno strascico di trionfalismo pubblico. Su questa tonalità emotiva vengono accordate le scelte stilistiche di Zero Dark Thirty, come volessero seguire la scia intramuscolo della condizione esistenziale che caratterizza l’attrice trainante, sacrificando ogni spettacolarità ostentata sull’altare di un fine che trascende, nel bene e nel male, il “semplice” cinema. Quasi servendosi di esso, utilizzando la finzione per ricostruire la realtà, così da amplificare quanto mostrato (già) con The Hurt Locker. E se a Zero Dark Thirty è lecito rimproverare una disequilibrata gestione della suspense (funzionale durante il crescendo investigativo, sorprendentemente meno in sede di sottofinale: da Loveless in avanti frangente sempre e comunque devastante nel cinema “bigelowiano”) e una certa verbosità manifesta, figlia della schiacciante responsabilità intrinseca nel racconto; è altrettanto giusto utilizzarne i pregi per celebrare la sua autrice. Perché, se negli Stati Uniti esiste un cinema d’azione “alto”, identificabile in Michael Mann, e uno politico altrettanto elevato, riconducibile a Clint Eastwood, Zero Dark Thirty offre la possibilità di percepire quanto Kathryn Bigelow sia ormai in grado di maneggiare entrambe le specialità. Aggiungendoci maledettamente del suo.